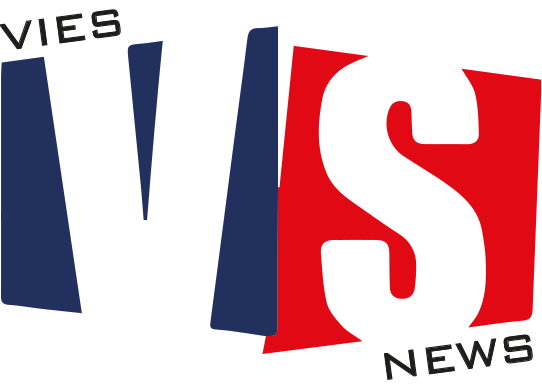[ Leggi dalla fonte originale]
A nessuno è permesso di sbagliare, di avere un difetto, di fallire. Un nuovo libro rovescia questo mantra collettivo e ci indica che il benessere mentale passa anche attraverso le fragilità
Connect
di Antonella Paglicci
Dagli adulti ai ragazzi, dalle famiglie alle scuole fino ai luoghi di lavoro, si respira la sensazione che quella “società della performance” che ci ha contrassegnato negli ultimi decenni è ormai in pieno tracollo. E che adesso si sfoga con venti forti di ansia, paura del futuro, instabilità psichica, ci spiega Giulio Costa, psicologo e psicoterapeuta, nel suo saggio La disciplina dell’imperfezione (Sperling&Kupfer), effetto di un “cambiamento psicologico” trasversale: abbiamo rimosso dalle nostre menti il concetto di fallimento e debolezza.
Adesso, niente è più peccaminoso che avere un difetto, che ammettere una difficoltà, che rivelare un cortocircuito personale. Costi quel che costi è indispensabile la repressione della falla. Tutti ci devono vedere al massimo in qualsiasi situazione, come se dai social (ma non solo) mandassimo 365 giorni all’anno cartoline di felicità ed eccellenza a raffica. Tutti sanno che l’eterno sorriso stampato in faccia è poco credibile e, ancora meno, veritiero ma è meglio coltivare le apparenze che rinunciare a questo delirio d’onnipotenza.
Dottor Costa, da quando abbiamo eliminato la parola “fragilità” dal nostro vocabolario?
Il dominio della prestazione non è nato adesso, ma è l’esito di un processo che dura almeno da quarant’anni. In questo arco di tempo, abbiamo cercato di allontanare da noi qualsiasi cosa che ci ricordi la morte, quindi l’angoscia, il dolore, la perdita, l’insuccesso, il lutto. E il modo più immediato per cancellare l’intera semantica legata alla vulnerabilità è stato estremizzare il “performare”, in qualsiasi sistema della nostra esistenza. Il ritornello sovrastante è stato: “devo funzionare bene all’interno delle relazioni familiari”; “non posso permettermi di riconoscere che ci sono problemi nella coppia”; “non posso accettare che i miei figli non siano bravi a scuola e non diventino campioni dello sport”; “al lavoro, non posso chiedere aiuto o dire a voce alta che non so qualcosa”. Abbiamo inquadrato la vita, insomma, in una cornice illusoria di impeccabilità per impedire di venire a contatto con quella parte di noi che parla, e tanto, di punti deboli, difetti, sofferenze.
Ma questa dimenticanza, basilare, cosa ha comportato?
Tanto, a partire dall’esperienza della pandemia che ci ha messo di fronte alla morte, all’imprevisto, al vuoto, al rallentamento, all’incertezza più traballante. Tutto ciò è stato un grande schiaffo in faccia, che ci ha riportato nel giro di pochissimo di fronte a questa angoscia che abbiano provato ad allontanare, cercando di marciare al massimo. Gli esiti peggiori li stiamo vedendo adesso, e sono tutti questi malesseri psichici in espansione, dall’ansia alla depressione, ai disturbi alimentari e a quadri ossessivi fino a un’ampia gamma di fragilità che ci accompagnano tutti i giorni.
Parlando del quotidiano, c’è qualche esempio significativo?
Parto dai ragazzi: sono tanti i giovani che si sentono in dovere di essere eccellenti a scuola, nello sport come in qualsiasi altra attività ricreativa, brillanti nella vita sociale per non sentirsi in colpa nei confronti sa a e, no a ra o: emi a ei o o n a, co o, ne, o, a e o dei genitori che hanno un investimento prestazionale a 360 gradi sui figli. Penso al lavoro: l’ormai diffusissimo smart working ha rischiato e rischia ancora fenomeni di burn out per fare vedere all’altro che sono “sul pezzo”, raggiungibile e connesso, quindi sempre nel pieno dell’efficienza. Poi il grande capitolo delle relazioni, a tutti i livelli, colpite dallo tsunami del rendimento: siamo immediatamente intolleranti e insofferenti nei confronti di tutti coloro (familiari, partner, amici, conoscenti, ecc.) che non soddisfano le nostre aspettative. E i legami sono sempre più friabili e a tempo determinato.
Perché, invece, includere la fragilità?
Arriviamo da anni in cui siamo stati bombardati da messaggi come “volere è potere”, “se vuoi puoi”, “il limite non esiste”, ma questa è una deriva che ci ha portato un grande malessere. Siamo stati imbottiti di quest’idea di onnipotenza e di efficacia illimitata che ci ha storditi e mandato in tilt perché non ha fatto i conti con le vere risorse individuali, le circostanze temporali e ambientali, l’imprevisto. Con la complessità dell’esistenza, insomma. Il limite, l’imperfezione, il nodo irrisolvibile, invece, esistono e sono presenti in ciascuno di noi. Riconoscere (e accettare) questo dato, fondamentale, ci fa diventare consapevoli della nostra umanità, e quindi molto più incisivi nell’affrontare le difficoltà che, più o meno, la vita ci riserva.
Il motivo?
Chi riconosce le proprie oscurità, sa anche dare un nome (e, quindi, concretezza) alle emozioni che prova nelle situazioni critiche. Riconoscerle è fare un passo avanti, significa essere disposti ad accogliere queste sensazioni negative. Abbiamo ricevuto una diagnosi di malattia, per esempio? In questa situazione, essere umani ci concede la normalità di provare paura, dolore e, insieme, accettare che non possiamo cambiare il fatto. Possiamo, però, adeguarci, attraversando la sofferenza, perché anche da quest’esperienza c’è da imparare qualcosa. E ciò rende la vita degna di essere vissuta.
Accogliere il buio dentro di noi che risultato ha?
Dà un sostegno diverso, più realistico e favorevole, alle nostre azioni. Ormai, siamo mossi da un concetto diffuso di dovere supremo e schiacciante: “devo essere bello, di successo, ricco, avere tanti amici e follower” e lo scopo va ottenuto a super velocità e senza fatica, animati come siamo dalla volontà accecante di dare un esito istantaneo a tutto ciò che facciamo. Niente di più fuorviante, ed ecco allora che cadiamo in trance. Per scappare da questa strada senza uscita crediamoci, invece, eroi, nel senso etimologico del termine. L’eroe, infatti, non è colui che trionfa con facilità, viene premiato e diventa famoso. Ma chi s’impegna, si sacrifica, sbaglia, piange, crolla, mette in dubbio se stesso. Più che un vincente è un coraggioso, e la sua forza deriva una scelta di base: si muove sulla scia di una passione – non di un imperativo categorico – che lo incuriosisce, lo motiva, lo accende e gli permette, perciò, di affrontare gli alti e i bassi di un percorso di autorealizzazione.
Non vuole dire soccombere a noi stessi?
Tutt’altro, significa crescere. Noi inseguiamo la chimera che solo nel controllo, nella metodicità dello schema, nella chiarezza d’intenti possiamo andare avanti nel migliore dei modi. Invece è proprio in un’esperienza di crisi, di distacco, di fragilità che mettiamo in atto risorse psichiche nuove che poi ci torneranno utili anche in contesti molto distanti tra di loro. È da questi anticorpi interiori che nasce la vera resilienza.
Alla fine dove porta un’esperienza di fragilità?
A fare un salto di qualità esistenziale. Se la riconosciamo e la viviamo nel profondo, mettiamo ordine alle nostre ferite e, di conseguenza, siamo in grado di trovare, con tempi e modi assolutamente soggettivi, in noi stessi le priorità che costruiscono la nostra felicità. E che non appartengono a quello che gli altri si aspettano da noi, dal momento che non abbiamo più l’ansia di soddisfare desideri e angosce performative esterne.
Conviene quindi provarci?
La vita è paragonabile alla navigazione, durante la quale si scatenano delle tempeste, piccole o grandi che siano, che inevitabilmente ci appartengono. Se facciamo di tutto per evitarle, esaltandoci di poter governare l’ingovernabile, finiamo per non goderci niente del viaggio, immersi come siamo nel terrore di aspettare la prossima burrasca. Non si tratta di schivare la furia dei cieli quanto di rendere sicura la nostra imbarcazione, che siamo noi, la nostra interiorità, le nostre relazioni, la cura dell’altro. Così diventa più facile mettere insieme quei punti fermi che ci permettono di tracciare la rotta e di vedere, con qualsiasi mare, l’orizzonte.
Fai la tua domanda ai nostri esperti
Leggi anche
Load More