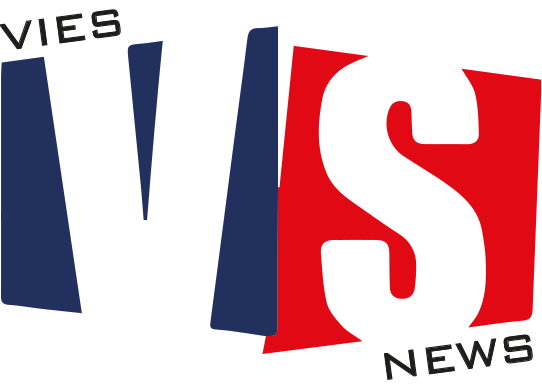[ Leggi dalla fonte originale]
Ha compiuto 50 anni (e sette mesi) la legge italiana che il 6 dicembre del 1971 con una rivoluzione culturale istituì in Italia gli asili nido comunali: l’assistenza (sì, la parola allora era questa) dei bambini fino a 3 anni diventava un progetto sociale di interesse pubblico. Nella spinta straordinaria delle norme che nel decennio tra il 1970 e il 1980 modificarono completamente la società italiana (divorzio, aborto, diritto di famiglia, statuto dei lavoratori, tutela delle lavoratrici madri, la rivoluzione dei manicomi di Franco Basaglia che mise fine all’internamento dei malati psichici), la legge 1044 sui nidi prevedeva la costruzione di 3.800 asili nido tra il 1972 e il 1976. Il progetto invece fallì e l’Italia rimase per tutta la seconda parte del Novecento agli ultimi posti in Europa nella rete dei servizi da 0 a 3 anni. Nonostante esperienze straordinarie e celebrate in tutto il mondo come gli asili di Reggio Emilia.
Era il 1991 quando Newsweek dedicò la sua copertina all’asilo Diana, inaugurato nel 1971, per celebrare quella rete di nidi e di materne considerate all’avanguardia nel pianeta. Erano gli albori del famoso “Reggio Approach” basato sulla pedagogia di Loris Malaguzzi, diventato oggi un metodo esportato e studiato in tutto il mondo. Ma già nel 1969, anticipando dunque la legge nazionale, grazie ad Adriana Lodi, assessora del Pci, Reggio Emilia aveva aperto i primi nidi comunali, trasformandosi nella città “modello” per i servizi per l’infanzia.
Ed è da Reggio Emilia che bisogna partire per capire cosa sia successo in Italia dal 1971, perché l’Italia sul fronte dei nidi ha visto regioni avanzatissime e regioni, quasi sempre al Sud, dove il nido è ancora oggi una realtà sconosciuta. Con i poli opposti del “Reggio Approach” da una parte, con il 55% dei bimbi 0-3 iscritti al nido, e la Calabria, dove la percentuale precipita al 2,6%.
Un paese spezzato in due
Un’Italia spezzata in due sulla concezione dell’infanzia, i cui riflessi si sono riverberati sulla lentezza con la quale un pezzo del nostro paese ha scritto i bandi per poter ottenere i fondi del Pnrr che davvero, questa volta, potrebbero riunire Nord e Sud sul futuro dei bambini. Un fiume di soldi dedicati alla costruzione di nidi: due miliardi e quattrocento milioni di euro, di cui soltanto grazie a ripetute “chiamate” (come spiega Isaia Sales nell’articolo qui sotto) alle regioni del Sud i bandi sono stati presentati e i soldi dunque destinati. Non tutti, però: fuori sono rimasti 400 milioni di euro che saranno utilizzati, sembra, per le scuole d’infanzia.
Con due enormi punti interrogativi: centinaia di asili nido saranno costruiti in un’Italia dalla demografia in calo vertiginoso (nel 2021 sono nati meno di 400 mila bambini). Allo stesso tempo, secondo una stima fatta da Alleanza per l’infanzia (uncentro studi “al servizio di bambine, bambini e adolescenti in Italia”, fondato da Chiara Saraceno), per gestire i nuovi nidi serviranno oltre 45 mila educatori professionali. I comuni avranno le risorse per pagarli, visto che i fondi del Pnrr sono destinati unicamente alle strutture e non al personale? Ma soprattutto, si troveranno educatrici ed educatori, dato il numero esiguo di giovani che scelgono questa professione, mal pagata e spesso ritenuta poco più che un semplice accudimento?
Emmanuele Pavolini, ordinario di sociologia all’università di Macerata, è coordinatore dell’Alleanza per l’Infanzia. Ossia di una rete di associazioni, soggetti, università, istituzioni, fondazioni che hanno a cuore il futuro dei nostri bambini e fanno progetti per orientare su questi temi la politica italiana, di solito sorda e lenta ai temi dell’infanzia.
“Il problema come sempre è strutturale. I comuni dove già esistono da tempo buone o eccellenti esperienze di nidi hanno fatto in tempo utile i bandi. L’Emilia Romagna ad esempio, tanto per citare una regione simbolo, ha esaurito subito la propria quota. Mentre molte realtà del Sud hanno faticato proprio nello scrivere i bandi. In molti comuni “poveri”, in condizioni di dissesto finanziario, il timore di non riuscire a reggere la gestione economica dei nuovi nidi ha sicuramente rallentato le domande. Una sorta di sfiducia istituzionale: se quest’anno il governo ha stanziato fondi per il funzionamento dei nidi, poi li rifinanzierà negli anni a venire? Le famiglie saranno in grado di pagare le rette?
Il paradosso dell’accesso
I nidi infatti non sono gratuiti e le famiglie pagano a seconda di reddito e condizione. Le rette, a meno di non essere quasi in una condizione di indigenza, possono risultare davvero faticose in nuclei con un solo stipendio, ad esempio. Con il paradosso che le regole di accesso favoriscono le coppie in cui entrambi i genitori lavorano, quindi con un doppio reddito, per le quali è fondamentale avere un posto dove lasciare i figli. Così è “naturale”, in senso ironico, che in quei pezzi d’Italia in cui l’occupazione femminile è scarsa o inesistente, e torniamo al Sud (33% di donne che lavorano contro il 59,2% del Centro-Nord, dati 2019 Confcommercio) i piccoli restino a casa, visto che le mamme sono disoccupate. Soltanto fino a due anni però, perché poi, conferma Pavolini, “in particolare al Sud c’è la corsa ad iscrivere i figli nelle sezioni di scuola dell’infanzia che accettano i bambini prima dei tre anni”. Le regioni meridionali hanno anche il record di studenti anticipatari, cioè iscritti alla prima elementare a cinque anni e non a sei.
“Questo ci dice che la resistenza è culturale soltanto in parte ed è più una questione di rette. Mandare al nido i figli in molte realtà costa troppo. E se c’è la mamma in casa, perché affrontare anche quella spesa? Qui sì, la questione diventa culturale”, spiega Pavolini. “Non è abbastanza radicata la concezione del nido come primo passo del progetto educativo 0-6 anni. Si pensa ancora troppo ai nidi come luoghi di accudimento o di “parcheggio” dei propri figli. O al nido come strumento di conciliazione puro e semplice per far sì che le donne lavorino”.
Cose fondamentali e concrete. Certamente gli asili nido hanno fatto da volano all’occupazione femminile, basta guardare i dati. Nel Centro-Nord, dove l’offerta di nidi raggiunge e in alcune regioni supera l’obiettivo europeo di 33 posti ogni 100 bambini, il tasso di occupazione femminile è del 59,2% (contro il 63% dell’Unione Europea). Nel Sud (in certe regioni più di altre, la Calabria ad esempio) l’offerta dei nidi precipita a 13,5 posti ogni 100 bambini; a Crotone i posti sono appena 4 su 100 (dati osservatorio “Con i bambini”). Per citare un dato scontato, in queste stesse regioni senza nidi l’occupazione femminile non supera il 33%.
C’è però qualcosa di molto altro, come ricorda con tenacia Daniele Novara, pedagogista e scrittore: “Più di duemila ricerche scientifiche dimostrano quanto frequentare un nido aiuti il bambino nel suo sviluppo psicoevolutivo. È una formidabile opportunità che poi si ritrova nella vita adulta. Mi accade spesso, con i miei studenti, di notare delle differenze. Quasi sempre scopro che i più brillanti sono andati al nido”.
Oggi siamo di fronte ad una svolta. I fondi del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) potrebbero modificare la geografia dell’Italia sul fronte della prima infanzia. Unificandola. Le incognite e le ombre però restano. “Io tendo a vedere il bicchiere mezzo pieno, adesso che tutte le regioni hanno presentato i bandi. Resta il problema delle rette e delle modalità di accesso. Se queste non cambieranno l’effetto paradossale dell’aumento dell’offerta, grazie ai fondi del Pnrr, sarà un aumento delle disuguaglianze e non di opportunità. Se cioè l’accesso continuerà ad essere privilegiato per le famiglie in cui entrambi i genitori lavorano e possono pagare una retta, i nidi resteranno appannaggio di borghesia e classe media. Già oggi abbiamo visto che la frequenza al nido è direttamente proporzionale al livello di istruzione della madre”.
Insomma, suggerisce con una battuta Pavolini, “si rischia quello che in sociologia si chiama Effetto San Matteo: ossia quando una misura sociale, nata per ridurre i divari, sortisce l’effetto contrario e acuisce invece le differenze”. Un effetto non da poco, se si pensa che nei primi mille giorni di vita si gettano le basi emozionali per tutto il resto della nostra esistenza.
I fondi del Pnrr
Ormai gli studiosi non hanno dubbi: frequentare il nido, per usare le parole di Novara, “apre praterie di possibilità. Sono la nostra migliore istituzione pedagogica, aumentano il livello intellettivo dei bambini, la loro autonomia, la loro capacità di relazione, eppure ci sono ancora molte resistenze. Da parte di alcune comunità immigrate, ad esempio, che faticano a far uscire il bimbo piccolo dal nucleo familiare, temendo in un certo senso una perdita di identità. Ancor più grave però – denuncia Novara – è l’atteggiamento scoraggiante di molti pediatri nei confronti dei nidi, perché lì i bambini si ammalano troppo. È vero, è naturale, ma non è meglio prendersi le prime malattie al nido e non poi alla scuola dell’infanzia? La verità è che c’è un filone della pediatria che non riesce più a vedere il bambino nella sua interezza”.
Non solo. Seppure rari, sono stati pubblicati negli ultimi dieci anni diversi pamphlet dichiaratamente contrari ai nidi. La tesi è che spodesterebbero il bambino del suo diritto a restare in famiglia nei primi anni di vita, anche se per questo le mamme dovessero rinunciare al lavoro. Tesi per fortuna poco seguita.
Tornando ai fondi del Pnrr, Daniele Novara, come Pavolini, sottolinea il rischio di creare strutture vuote sia per un problema demografico, sia per la mancanza di personale. “Dobbiamo chiederci perché i tanti giovani che escono dalle facoltà di Scienza dell’Educazione poi non vogliano lavorare nei nidi”. Rischiamo quindi di trovarci nei prossimi anni a crescita zero di fronte a bellissimi asili desolatamente vuoti, nonostante oggi si parli di progetti educativi 0-6?
Daniela Del Boca, economista e autrice di una delle prime ricerche in Italia sugli effetti dei nidi per lo sviluppo cognitivo dei bambini, dice che il pericolo c’è. “In questi anni, sia in Piemonte che in Lombardia, dove l’offerta dei nidi è massiccia, abbiamo visto con sorpresa una contrazione delle domande. Dietro questo calo si sommano due fattori: la bassissima natalità e gli orari troppo rigidi. Orari che durante la pandemia sono mutati ancora di più. Il lavoro oggi è flessibile – turni, part time, mattina o pomeriggio, periodi intermittenti – mentre i nidi seguono ancora uno schema tradizionale, dalle 8 alle 16. Tutto questo non corrisponde più alla vita delle famiglie”.
Allo stesso tempo, suggerisce Del Boca, ci vogliono campagne informative sull’importanza dei nidi. “Molte famiglie immigrate, lo vedo a Torino, preferiscono tenere i bambini in casa fino ai tre anni, quando possono inserirli nella scuola dell’infanzia. Mentre per questi bambini e anche per le loro madri il nido potrebbe costituire la prima forma di integrazione”.
Flessibilità è la parola che rilancia anche Susanna Mantovani, un’autorità in materia di nidi d’infanzia, docente onoraria di Pedagogia generale dell’università Bicocca, oggi presidente della commissione sul sistema integrato 0-6 del ministero dell’Istruzione. E, soprattutto, fondatrice dell’asilo nido della Bicocca. “Lentamente le regioni si sono organizzate, hanno presentato i bandi, quindi un grande passo in avanti è stato fatto. Poi naturalmente bisognerà far sì che queste nuove strutture costruite con i fondi del Pnrr vivano. In un paese con una bassa natalità come il nostro – dice Mantovani – è importante pensarle flessibili, modulabili, oggi per i piccoli da zero a tre anni domani per la scuola dell’infanzia, immaginare micro nidi, orari part time, sezioni primavera. Il nido è un diritto del bambino, ma deve andare incontro anche alle esigenze della famiglia”.
Ci vogliono tecnici, educatori, progetti, aggiunge Mantovani. “I buoni servizi richiamano utenza ed è sulla qualità che bisogna puntare. E su una informazione capillare su quanto sia fondamentale e bello che i bimbi possano iniziare il loro percorso formativo fin da piccolissimi”.
Asilo Nido Loris Malaguzzi, Roma. Fonte: L’Espresso
La questione meridionale
di Isaia Sales
Si è concluso il 31 maggio l’ultimo bando per gli asili nido con ulteriori 70 miliardi messi a disposizione dal “Pnrr-Istruzione” per le regioni meridionali, con priorità alle domande provenienti dai comuni della Basilicata, del Molise e della Sicilia, in quanto per queste regioni non era stato raggiunto il budget loro assegnato. Anche per il bando precedente era stata necessaria una proroga dal 28 febbraio al 31 marzo perché il numero delle richieste provenienti dal Sud era inferiore alla disponibilità del 40% che, come è noto, è riservato dal Pnrr ai territori al di sotto del Garigliano.
Lo sforzo fatto dai vari ministeri, a partire da quelli retti da Patrizio Bianchi e Mara Carfagna, non è stato vano: i due bandi complessivamente hanno raggiunto un numero di domande che garantisce un passo avanti nella dotazione di asili nido nei comuni meridionali e la quota loro riservata è andata oltre il 40%. Ad oggi le regioni da cui sono arrivate più richieste sono nell’ordine la Campania (206), la Lombardia (157), la Calabria (144) e il Lazio (138). E dalle tre regioni più in ritardo (Molise, Basilicata e Sicilia) le richieste arrivate entro il 31 maggio sono in linea con le disponibilità finanziarie. Questa volta la Sicilia ha presentato altre 22 domande, il Molise e la Basilicata altre 9.
Tutto bene, allora? No. Al di là di questo sforzo notevole per garantire che le risorse raggiungano gli obiettivi fissati, forse è venuto il momento di una riflessione più ampia sulle misure adottate per fare fronte alla sproporzione di servizi tra Centro-Nord e Sud, di cui la dotazione differenziata di asili è uno degli esempi più clamorosi in Italia.
La prima domanda da porsi è la seguente: siamo sicuri che la migliore scelta per ovviare a questa sproporzione sia la selezione con bando pubblico dei bisogni da soddisfare? In fondo, sappiamo esattamente quanti asili mancano nei territori meridionali per avvicinarli alla dotazione delle regioni del Centro-Nord e lo sanno benissimo i vari ministeri preposti. Non conveniva stabilire per ogni comune una soglia minima di dotazione di questo servizio assegnando le risorse a chi è sotto quella soglia e poi, successivamente, provvedere a quelli che l’hanno ampiamente superata?
In effetti, c’è una trappola nell’Italia diversamente dotata di asili: chi ha già uno standard ottimale vuole averne di più e accusa chi sta indietro di volerne bloccare l’ulteriore crescita, mentre chi questi servizi non li ha deve prima dimostrare (partecipando ai bandi) di voler colmare questo gap, anche se le risorse non sono sufficienti a gestirli o gli uffici non sono attrezzati neanche per presentare le domande.
Quindi viene spontanea un’altra riflessione: l’incapacità o l’impossibilità di chi amministra localmente di soddisfare bisogni elementari dei cittadini possono privare questi ultimi di ciò che lo Stato ritiene fondamentale per la formazione dei loro figli? Per i servizi essenziali non sarebbe utile applicare meccanismi di sostituzione del comune inadempiente? Non è più saggio stabilire che, se c’è un bisogno civile non soddisfatto, altre istituzioni si assumano il compito di farlo in sua vece? Altrimenti si verifica il paradosso che l’inefficienza di una parte del Paese (senza servizi) premia l’altra che ne ha meno bisogno.
Scuola d’infanzia Clorofilla, Milano. Fonte: L’Espresso
Ciò vuol dire, forse, che nessun altro comune italiano, al di fuori di quelli meridionali, deve chiedere finanziamenti e costruire altri asili nido? No, assolutamente. Ma se si accede a finanziamenti dello Stato (e non si ricorre a risorse proprie) sarebbe equo che si seguisse un obiettivo di riequilibrio prima di aumentare ulteriormente gli squilibri! In quale parte della Costituzione sta scritto che a condizioni economiche differenziate deve corrispondere necessariamente anche una diversità di dotazioni di servizi? Più disoccupati e meno asili? Senza lavoro e senza servizi?
Sono questi i paradossi di un sistema istituzionale che lascia tutta la responsabilità agli enti territoriali. L’ipocrisia dell’autonomia locale che se inefficace viene punita dagli elettori ha fatto ampiamente il suo tempo.
Insomma, bisognerebbe rapidamente passare ad un’altra fase dell’istruzione pubblica in Italia, nella quale è prioritario garantire l’asilo nido a tutta la popolazione in età da zero a tre anni al di là delle domande fatte dai comuni e delle loro disponibilità finanziarie per gestirli. Perché è indubbio che se si è riusciti nel 2015, con la legge sulla “Buona scuola”, a fare rientrare (finalmente) gli asili nido nel campo dell’istruzione e non dei servizi sociali a domanda individuale, ora è necessario un ulteriore e conseguente salto in avanti politico, culturale e civile. E se, com’è giusto, alcuni beni pubblici sono ritenuti fondamentali (cioè se nessuno degli aventi diritto ne può essere privato al di là di chi amministra localmente e delle risorse che quel singolo comune ha a disposizione per gestirli) essi debbono essere universali, cioè gli asili debbono coprire tutto il fabbisogno dei richiedenti, come avviene per la scuola primaria e secondaria. Certo, ciò deve avvenire gradualmente ma con una strategia che sia chiara, definitiva e valida su tutto il territorio nazionale.
Vediamo come stanno le cose nelle varie regioni in rapporto agli asili già costruiti e funzionanti. Rispetto al 33% di rapporto tra posti disponibili e totale dei bambini che l’Unione Europea poneva come obiettivo da raggiungere entro il 2010, l’Italia ha una media del 25,47%, cifra che comprende anche l’apporto di asili privati. Ma questa media è formata dal 38,87% del Lazio e dal 9,3% della Campania, dal 37,44% dell’Umbra e dal 9,54% della Sicilia, dal 36,94% dell’Emilia Romagna e dall’11,03% della Calabria, dal 36,91% della Toscana e dal 17,78% della Basilicata, dal 29,99% della Lombardia e dal 18,03% della Puglia, dal 29,5% del Veneto e dal 19,71% dell’Abruzzo. Nella graduatoria sembrano in controtendenza i dati della Sardegna (28,4%) e del Molise (24,88%) che si allineano alle statistiche dell’Italia centrale, ma nonostante ciò non c’è nessuna regione meridionale che superi una del Centro-Nord.
Se questa era ed è la situazione, si poteva agire diversamente per modificarla in senso più equo? Una soluzione semplice esisteva: prendendo come obiettivo il 33% di copertura richiesto dai parametri dall’Unione Europea, si finanziavano tutti i comuni al di sotto del parametro fino al suo raggiungimento, cioè tutte le regioni meridionali più quelle del Centro-Nord al di sotto della media. Ciò invece non è stato fatto: è indubbio che grazie alla riserva del 40% molte regioni meridionali miglioreranno la loro dotazione di asili, come abbiamo visto, ma lo faranno anche quelle che già ampiamente superavano la dotazione standard. Sarebbe stato più giusto avviare con le risorse del Pnrr (a cui aggiungerne altre nazionali) un piano di costruzione e gestione di asili nido come avvenne per la scuola primarie e secondaria pubblica: ogni bambino da zero a tre anni deve poter andare all’asilo in qualunque parte d’Italia, perché l’asilo è riconosciuto come un diritto universale e quindi non deve contare il tuo reddito, non deve contare dove sei nato, dove vivi e chi ti amministra!
Nido d’inganzia Gianni Rodari, Reggio Emilia. Fonte: L’Espresso
Come mai si è formata questa disparità così alta tra diverse regioni del Centro-Nord e del Sud, e qualche volta all’interno delle stesse regioni del Centro-Nord? Sicuramente nel tempo hanno inciso diversi fattori. Essendo l’asilo una competenza essenzialmente locale, si è riprodotta una differenza di servizi sulla base delle risorse a disposizione dei singoli comuni. In effetti è avvenuto nel campo degli asili nido quello che avvenne nei primi anni dopo l’Unità d’Italia nell’istruzione primaria: poiché i maestri e le maestre erano pagati dai comuni, molti sindaci non diedero corso all’obbligatorietà dell’istruzione in base a un calcolo economico di convenienza o a causa della scarsità di risorse. In questo modo l’Italia, che era arrivata all’unificazione con tassi di analfabetismo più alti nel Sud, li vide ampliare nei decenni successivi a causa di questo assurdo: istruzione di base obbligatoria per tutti, ma garantita a seconda delle risorse delle amministrazioni locali!
La situazione cambiò radicalmente quando i maestri furono pagati dallo Stato, azzerando il costo per i municipi. Intanto però il guaio era stato fatto; ci vollero decenni per recuperare, cosa che avvenne essenzialmente con la scuola di massa nel secondo dopoguerra, grande riforma del centrosinistra, che eliminò completamente l’analfabetismo.
Ha influito, certo, anche la diversa situazione del mercato del lavoro nel Centro-Nord. Per consentire a più donne di svolgere la loro attività lavorativa era necessario dotarsi di strutture pubbliche. L’asilo, infatti, considerato più uno strumento di emancipazione delle donne che un primo momento di socializzazione e di istruzione fuori dalla famiglia, divenne la principale rivendicazione dei sindacati, del mondo imprenditoriale e degli stessi movimenti femministi. Le loro istanze trovarono maggiore ascolto in alcuni partiti che amministravano gli enti locali. Gli asili nido, e poi le scuole materne, divennero uno dei fiori all’occhiello del riformismo municipale e della realizzazione di servizi pubblici di stampo europeo nella parte del Paese che più si sviluppava economicamente, produttivamente e socialmente. L’Emilia Romagna fu in testa a questo movimento che interessò tutto il Centro-Nord, meno il Sud proprio a causa della minore partecipazione delle donne al mercato del lavoro.
L’asilo nido della-fondazione Mast, Bologna. Fonte: L’Espresso
Non bisogna dimenticare che in passato i sindaci meridionali hanno fatto meno richieste di asili sia alla Cassa Depositi e Prestiti sia in base a specifiche leggi nazionali. Certo, alcuni di essi hanno ritenuto che costruire un’opera pubblica di abbellimento fosse più importante che costruire e gestire un asilo, ma in genere lo scoraggiamento veniva dalle difficoltà dell’indebitamento e dei costi di gestione. Anche nel bando scaturito da un decreto del 2017 (che per la prima volta stanziava risorse specifiche solo per gli asili nido) l’esigenza di riequilibrare in senso territoriale il finanziamento di nuovi asili era relegata a semplice “eventualità”, come ricorda Marco Esposito nel libro Fake Sud. Il criterio del riequilibrio nei servizi è un dovere pubblico, non può essere una eventualità!
Ora però che il finanziamento con il Pnrr è 10 volte superiore si deve cambiare strada. Il bando deve essere fatto per l’impresa che deve costruire l’asilo, non per selezionare i bisogni territoriali. Che sono ampiamente noti. Lo ripeto: al Sud ci sono in linea di massima tre volte meno asili che al Centro-Nord. Non è accettabile. I test Invalsi che vedono una minore propensione degli alunni meridionali verso alcune materie potrebbero dipendere anche da questa sproporzionata presenza di strutture per l’infanzia. La povertà educativa è definita da Save the Children come “la privazione della possibilità di apprendere, sperimentare, sviluppare e far fiorire liberamente capacità, talenti e aspirazioni”. Se gli stimoli per un bambino debbono arrivare fin dal primo giorno di vita, non possiamo lasciare che ciò avvenga solo all’interno delle rispettive famiglie. La povertà educativa non è inevitabile e non è irreversibile. È lo Stato che con le sue scelte può consentire che “non si diventi quello che si è nati”, come in molte realtà meridionali purtroppo sempre di più avviene. A partire dai quartieri popolari e da quelli sorti troppo numerosi nelle periferie urbane. Se poi le famiglie vogliono scegliere un asilo privato, ciò deve restare nell’ambito di una loro volontà e non di una necessità.