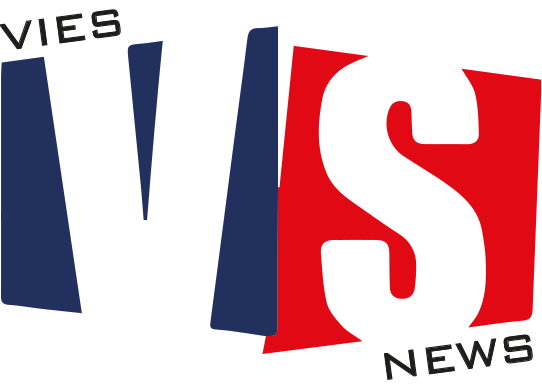[ Leggi dalla fonte originale]
C’è una battuta illuminante che Luca Marinelli fa dire al suo Mussolini: «Dobbiamo trasformare la paura in odio». È quello che Marco Minniti, ex ministro degli Interni, presidente della Fondazione Med-Or, teme che possa di nuovo accadere.
«Partiamo da un punto: gli attacchi alle forze di polizia così come quello alla sinagoga di Bologna sono inaccettabili e ingiustificabili. Perché in una democrazia deve esserci libertà di espressione anche per le posizioni più radicali. Però c’è un limite che non può essere superato: la violenza”.
La morte di Ramy Elgaml non può però essere archiviata soltanto come un incidente.
«L’esigenza espressa con grande nettezza dalla famiglia di Ramy, da suo padre, da suo fratello, e cioè che su quella morte ci debba essere verità e giustizia, è sacrosanta. Tuttavia non possiamo non vedere che queste due persone che amavano e amano Ramy dicono che gli strumenti violenti non soltanto non aiutano ma rischiano di allontanare la verità. Oggi, pur facendo sentire la forza dell’opinione pubblica, dobbiamo essere tutti rispettosi e consapevoli che la partita è nelle mani della magistratura che sta indagando con straordinaria responsabilità».
Scontri a Bologna per Ramy, Lepore: “Atti vandalici alla sinagoga”. Dieci feriti tra gli agenti
Insistiamo: la morte di Ramy non è soltanto un incidente. Sta succedendo qualcosa di diverso.
«È evidente che dietro quello che sta avvenendo c’è un problema più di fondo. E il problema sta nella necessità di comprendere la parola sicurezza nelle sue varie declinazioni: c’è quella fisica, quella sanitaria, quella ambientale, basti vedere come gli incendi stanno distruggendo Los Angeles, un mito della modernità. E poi c’è la sicurezza sociale. Ecco: sicurezza è la parola chiave per coloro che pensano sia aperta la sfida tra autocrazie e democrazie, perché nonostante qualcuno dica il contrario, la sicurezza è un tema fondativo della democrazia. Ed è fondativo soprattutto per i ceti più esposti, quelli popolari, che vivono e abitano le nostre periferie. Sono loro, che vedono da vicino ogni giorno violenze, diritti negati, a venire colpiti più facilmente da quello che chiamo il sentimento della paura. Nel momento in cui sono in servizio permanente ed effettivo i mercanti della paura, la democrazia deve sapere parlare a quei cittadini che hanno paura per il loro presente e sono angosciati per il loro futuro».
Detta così, però, sembrano parole lontane dalle risposte concrete che proprio i “ceti più esposti”, come li definisce lei, chiedono con urgenza.
«E invece parlo di cose concrete. Per una politica di sicurezza non sono sufficienti le statistiche. C’è bisogno di entrare in contatto con la quotidianità della gente. E non si può ridurre tutto all’ordine pubblico. Mi spiego: per rendere più sicura una piazza non basta la macchina della polizia nel centro. C’è bisogno che quella piazza sia sufficientemente illuminata, che ci siano politiche sociali, urbanistiche serie e mirate».
Che si deve fare quindi?
«Rilanciare una nuova stagione dei patti per la sicurezza che consentano allo Stato e ai sindaci di lavorare insieme. Le esigenze di sicurezza sono diverse, a seconda dei luoghi. I sindaci conoscono le esigenze dei loro territori meglio dello stato nazionale che deve mettere a disposizione, caso per caso, una valutazione generale. Il patto consente di avere una strategia comune in cui ciascuno recita il suo ruolo: lo Stato fa le indagini, il comune le politiche territoriali e sociali. Non c’è bisogno di avere sindaci sceriffi ma è necessaria invece cooperazione».
Il governo ha scelto la strada dell’aumento delle pene.
«Io credo che così come non bastano le statistiche, non sia sufficiente nemmeno l’aumento delle pene. Perché qui parliamo di zone franche dove lo Stato non c’è: se i criminali non vengono arrestati che senso ha parlare di pene? Qualche giorno fa abbiamo celebrato i dieci anni della strage di Charlie Hebdo, l’avvio di una stagione in cui abbiamo scoperto che coloro che ci hanno ferito a morte non arrivavano da lontano ma vivevano con noi. Erano i figli di una mancata integrazione, prodotti proprio di quelle zone franche a cui oggi è necessario prestare attenzione massima».
Ecco, appunto: non crede che la parola integrazione sia stata cancellata dal nostro vocabolario o peggio relegata a un termine buonista?
«L’integrazione è un pezzo fondamentale delle politiche di sicurezza, non è soltanto un aspetto gentile del porsi. Senza integrazione non può esserci sicurezza. Parlo di integrazioni tra nazionalità e religioni. Nel 2017 ci fu un patto per l’Islam italiano secondo me importantissimo: perché l’Italia, il paese in cui risiede la Chiesa, portava il massimo rispetto a un’altra dottrina e donne e uomini si dicevano orgogliosi di essere musulmani e contemporaneamente italiani. Nelle parole del padre di Ramy c’è un messaggio straordinario: anche nel momento del dolore più profondo, perché non c’è niente di più drammatico nel perdere un figlio, ci mette davanti un punto di vista che è dentro l’orizzonte e i principi di una grande democrazia. Chiede giustizia, non grida alla guerra santa».