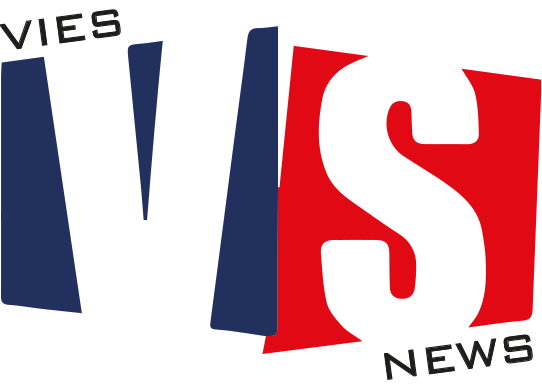[ Leggi dalla fonte originale]
VERONA – Togliersi la vita in carcere a 27 anni, dopo un lungo corpo a corpo con la tossicodipendenza. Il viso delicato di Donatella Hodo cela l’abisso da cui non è mai riuscita a riemergere. Ma la sua parabola è il dramma di tutti, anche del magistrato che doveva occuparsi del suo recupero. Il giudice Vincenzo Semeraro, 63 anni, marchigiano, in Veneto dal 2009, per una volta mette da parte il Codice penale. Prende carta e penna e scrive una lettera con il cuore, che viene letta durante il funerale. “Scusami Donatella, con la tua morte ho fallito anche io”.
Dottor Semeraro, sono parole pesanti le sue. Come mai dice di aver fallito anche lei?
“Perché quando una ragazza di 27 anni muore in carcere significa che tutto il sistema ha fallito. La magistratura di sorveglianza è un ingranaggio fondamentale, quindi io ora mi porto dentro un bel peso”.
Lei conosceva bene Donatella?
“Certo. L’avevo vista entrare in carcere a 21 anni, per furti e altri reati minori. Aveva una storia di dipendenza già pesante, con una vicenda personale drammatica per tanti motivi. Quella situazione mi aveva colpito. Aveva una personalità fragilissima ma nascondeva questa fragilità dietro una corazza. Aveva un carattere che poteva sembrare ostico, irritante. Ma non era così. Bisognava lavorarci a fondo, dedicarci tempo e pazienza”.
Realisticamente lei cosa avrebbe potuto fare di più?
“Non lo so precisamente cosa, ma so che si poteva fare di più: magari tenerla una mezz’ora in più quando veniva ai colloqui, o forse due parole di conforto in più. Dovevo forse impuntarmi e pretendere che provasse ancora ad andare in comunità. Mi vengono da fare tante ipotesi ma non so se tutto questo poi sarebbe servito”.
Ma questa ragazza c’era mai stata in comunità?
“Sì, l’avevo consigliata di fare domanda. Lo scorso mese di marzo era riuscita a entrare in una di queste strutture convertendo la pena ma a maggio era già in carcere di nuovo”.
Come mai? Cos’era successo?
“Quando in giugno tornai in istituto, lei chiese di vedermi e mi raccontò una storia di dissapori con gli operatori di quella comunità. Aveva infranto delle regole e loro si erano irrigiditi. Di fronte a quel muro alzato quasi subito, lei decise di scappare, salvo poi essere riarrestata di lì a poco. Dopo 16 anni come magistrato di sorveglianza posso dire che il primo periodo di ingresso in comunità è delicato e difficile. Per un tossicodipendente significa mettersi davanti a uno specchio e iniziare a lavorare sui problemi”.
In 16 anni avrà visto tante storie come quella di Donatela. Perché questa l’ha toccata al punto da scrivere una lettera di scuse?
“Lavorare con i detenuti significa parlare con loro, conoscerli. Ci sono casi che prendono di più e casi che prendono di meno. E non parlo di casi come di semplici fascicoli. Queste sono persone, vite. Donatella era innamorata di Leo, il suo fidanzato. Sperava tanto di uscire per ritrovarlo. Altre detenute che mi ero preso a cuore hanno cambiato vita e sono state reinserite nella società. Con lei non ci sono riuscito e questo mi fa soffrire”.
La sua lettera può essere interpretata anche come una forte critica al sistema carcerario. Non crede?
“Io penso che il carcere, così com’è, sia pensato per gli uomini e non per le donne. Perché tende a contenere la violenza e l’aggressività, che sono caratteristiche tipiche dell’uomo. Un penitenziario su misura per le donne dovrebbe esplorare di più l’ambito emotivo ma in Italia non c’è qualcosa del genere. Qui sì le donne sono parificate agli uomini, ma è un errore marchiano. La donna in carcere è un soggetto doppiamente debole: necessiterebbe di una tutela maggiore”.