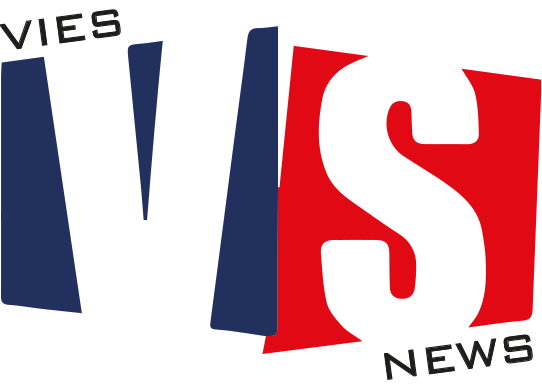[ Leggi dalla fonte originale]
Attingere alla realtà delle cose. Scendere dentro la miniera più autentica. Ascoltare ciò che accade intorno. Ciò che di più vero abbiamo dentro. Anche a questo serve l’estate. Renzo Piano aveva trentatré anni e nel 1971 viveva a Londra, a Hampstead. Era beat: libertà e ribellione per trovare sé stessi. Lontano dall’accademia e dentro la società. Si apprestava a dare vita a Beaubourg, la macchina colorata che ancora palpita, vivissima, a Parigi.
Architetto come ricorda quell’estate?“Eravamo ragazzacci e avevamo una specie di confusa ma lucida sensazione che qualcosa doveva cambiare”.
Lei e Richard Rogers, amici di una vita, avevate uno studio su Aybrook Street. Come lo aveva conosciuto?“Nel 1968 ero a Londra per una piccola mostra sui miei lavori sperimentali quando un medico che conoscevo passò di lì e mi chiese di accompagnarlo da un architetto inglese che aveva la rosolia. Era Richard”.
Luca Parmitano: “L’alba vista dalle stelle. Passeggiai nello spazio quel mattino di luglio”
di
Federico Pace
Cosa vi legò?“Richard era italiano, i genitori fuggiti dall’Italia quando vennero approvate le leggi razziali. È scattato qualcosa di molto bello che aveva a che fare con le affinità, con il modo di concepire il mestiere di architetto e la sua nobiltà, con l’ancoraggio alla realtà delle cose”.
Lei insegnava all’Architectural Association School, la scuola dei “ribelli”. Come erano le lezioni?“Alle dieci del mattino prendevo i miei ragazzi, attraversavo la strada in Bedford Square Garden e entravamo nel parco armati di chiodi, viti e pezzi di legno. Il compito era costruire qualcosa che si potesse realizzare e demolire entro le diciassette. Andavamo via quando il parco chiudeva”.
L’estate che mi ha cambiato la vita
Nicoletta Manni: “Quel provino a 12 anni che mi fece entrare sulle punte alla Scala”
di
Federico Pace
Poi a un certo punto veniste a sapere del concorso. Come capitò?“Venne in ufficio Peter Rice, un ingegnere straordinario del grande studio Ove Arup & Partners. Ci offrirono un po’ di soldi per partecipare. Quando hai quell’età lì, e un ufficio piccolo, anche qualche migliaio di sterline va bene”.
Dapprima foste incerti, il concorso sembrava magniloquente, un museo per la cultura a Parigi voluto da Pompidou. Poi scopriste che in giuria, diretta da Jean Prouvé, c’erano figure autorevoli come Oscar Niemeyer. Cosa faceste?“Io e Richard ci buttammo nell’avventura. Pensammo che la cosa giusta fosse rifiutare l’intimidazione tipica dei musei come luoghi privilegiati per persone colte. A noi da ribelli, ma non incolti, piaceva l’idea di aprire le porte e creare un luogo che sostituisse la curiosità all’intimidazione. Costruire una macchina, non un edificio. Cinque piazze sovrapposte, una sopra all’altra. Più una fuori, da dove si osservava la vita in movimento. Di tutti i progetti, il nostro era l’unico con una piazza”.
Chi inviò la candidatura?“Una ragazza del nostro studio, all’ufficio postale mezz’ora prima della chiusura. L’impiegato disse però che non poteva spedire il rotolo perché troppo lungo”.
Nives Meroi: “Quel 26 luglio 2006 quando raggiunsi in lacrime la vetta del K2 al terzo tentativo”
di
Federico Pace
E cosa successe?“Janet era intelligente. Si fece dare un coltellaccio, tagliò cinque centimetri e lo rimise dentro. All’impiegato non rimase che spedirlo”.
Dal concorso non vi aspettavate nulla. Faceste la vita di sempre. Cosa le piaceva di Londra?“I parchi. Andavo spesso ai Kew Gardens con i ragazzini. C’era questa meraviglia della serra, le palme. Un esperimento straordinario. Mi piaceva anche Richmond Park”.
E la musica?“Con i bambini sulle spalle andavamo di venerdì alle Proms, le Promenades, i concerti gratuiti per strada o nelle sale. Rigorosamente in piedi. Duravano mezz’ora. Per noi la cultura era quella lì”.
Poi, alla fine di giugno, arrivò una telefonata?“È così. E fu un colpo”.
Perché?“La persona, dall’altra parte, parlava in francese e io con un francese scolastico non capivo. Continuava a ripetermi “vous êtes lauréat”. Per me lauréat voleva dire laureato. Certo che ero laureato, rispondevo. La signora impiegò quattordici minuti a farmi capire che avevamo vinto”.
Ferdinando Scianna: “Quell’agosto del 1963 quando incontrai Sciascia e diventai fotografo”
di
Federico Pace
E cosa avvenne dopo?“Ci fu chi provò a dire, va bene, questa è l’idea, adesso ce ne occupiamo noi. Figurarsi, noi eravamo delle bestie, e rispondemmo: a questo punto invece lo costruiamo noi”.
Così fu. Il 19 luglio eravate a Parigi al Grand Palais a presentare il progetto.“Fu un’estate molto calda. C’era da partire con il progetto e a quell’età, per noi, costruire un sistema di lavoro, non voleva dire prendere accordi, ma raccogliere attorno amici e persone fidate. Cominciammo a chiamare e componemmo una banda di giovani”.
Vi fermaste mai?“L’unica pausa che ricordo furono quattro giorni con mia moglie a Egina, un’isola greca”.
E questa estate?“Per me sono tutte speciali, anche questa tra i monti in mezzo ai boschi del Vallese svizzero. Con l’eccesso di informazione e il superfluo da cui siamo sopraffatti, c’è bisogno di silenzio e solitudine. Tutte le estati sono un momento da dedicare a liberarsi di ciò che è superfluo. Anche dentro di sé”.
Avvicinarsi a sé stessi. Anche quell’estate così turbinosa l’avvicinò davvero a sé stesso.“È così”.
Allora lei e Rogers incontraste il presidente Pompidou. Vi chiese se vi rendevate conto che stavate per costruire qualcosa che sarebbe durato cinquecento anni. Come reagiste?“Non ci spaventammo. A quell’età si è vagamente irresponsabili. D’altronde, ci domandammo, perché solo cinquecento?”.
I tempi dell’architettura.“Luciano Berio, amico fraterno, mi diceva sempre che la musica, come l’architettura, vive di tempi lunghi. Come le foreste, come i fiumi, come le montagne. Facciamo questa scommessa con lei: questo edificio tra cinquecento anni sarà ancora lì”