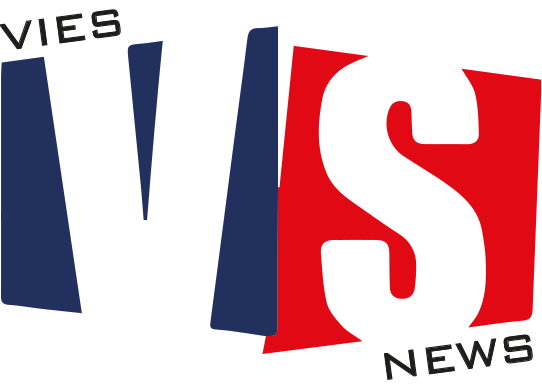[ Leggi dalla fonte originale]
Reputazione e apparenza, parole antiche ma inevitabilmente attuali. Ruota intorno a questi due concetti il nuovo romanzo della filosofa e scrittrice Ilaria Gaspari intitolato appunto La reputazione (Guanda), che ha per protagonista la titolare di una boutique nel quartiere Parioli di Roma, Marie France. Gli affari vanno benissimo fin quando la donna decide di aprire una linea per teenager. Da quel momento, giorno dopo giorno, la superficie della serenità apparente comincia a incrinarsi. Compaiono strani messaggi in codice, minacce e, intorno al negozio di moda, si diffonde una calunnia infamante. Una ragazzina scompare: esiste una relazione con quello che serpeggia in giro? Di fatto, la reputazione di Marie France e dei suoi è distrutta.
«Il nostro capitale reputazionale si basa soprattutto su come appariamo all’esterno», osserva Ilaria Gaspari. «Si dice, infatti, che viviamo nella società dell’immagine; io mi spingerei a dire che viviamo nella società delle apparenze. E non è un caso se il mio racconto è ambientato negli anni Ottanta, un decennio che è stato il laboratorio di ciò che accade oggi. In quegli anni, infatti, abbiamo assistito allo sviluppo dell’“edonismo”, una forma di individualismo, di spazio largo alla realizzazione personale che, oggi, vediamo esasperato e in scala molto più vasta. Quindi, ho usato il filtro di un passato abbastanza recente per indagare su quanto le apparenze pesino sul nostro quotidiano».
Ilaria, la reputazione è apparenza?
«Non sono la stessa cosa. Se guardiamo al significato della parola, la reputazione è il valore che viene attribuito a qualcuno mentre l’apparenza è la superficie (del nostro corpo, del nostro essere, del nostro modo di mostrarci al mondo) sulla quale si può fermare lo sguardo degli altri nel momento in cui ci vedono. È più immagine, più facciata, certo. Ma può riflettere delle cose profonde di una persona e viceversa. Secondo me, perciò, realtà e apparenza non sono così divise e in opposizione. Perciò, le apparenze contano nella nostra vita, e non in un modo necessariamente superficiale».
Quindi, la reputazione cos’è?
«Corrisponde all’idea che gli altri si fanno di noi e del nostro valore in senso generale. In questo caso, può essere anche qualcosa di brutale, di crudele, di ingiusto in quanto ci attribuisce nell’universo un posto che, magari, sentiamo di non avere perché può andarci stretto o che temiamo talmente di perdere che può condizionare tutti i nostri comportamenti».
In poche parole, è una valutazione che gli altri fanno di noi?
«Sì, ed è legata, rispetto all’apparenza, più a un giudizio morale e, soprattutto, a delle proiezioni esterne, cioè alle aspettative (di ruolo, di comportamento) che le persone si fanno sui di noi. Ha anche la caratteristica di essere ambivalente. Da un lato, può essere una spinta ad agire bene, dall’altro può essere una prigione o anche un mezzo di controllo sulle persone, come è stato per molto tempo per le donne, per esempio, costrette ad agire in un certo modo per mantenere una buona reputazione.
Viene costruita da noi o dagli altri?
«La reputazione è l’incontro tra queste due tensioni, ed è qui che si fa imprevedibile. Dipende sia dal modo in cui noi modelliamo il nostro stare al mondo sia dallo sguardo degli altri, che può essere effettivo o ipotetico. Però, il peso delle occhiate, delle parole delle persone è un aspetto totalmente indipendente dalla nostra volontà, che ha il potere di costruire dal nulla o distruggere in un attimo la nostra reputazione. Oggi più che mai, in questi tempi dominati dai social basta un click per essere portati in alto oppure venire cancellati».
Che legame c’è tra reputazione e conformismo?
«Un collegamento molto forte, poiché se non avessimo una spinta, trasversale e molto insistente, al conformismo non ci importerebbe assolutamente nulla della reputazione che abbiamo. Infatti, potersi permettere di non curarsi di averla buona è un atto di grande ribellione, oggi molto, molto raro. A tutti i livelli, siamo preoccupatissimi di cosa gli altri pensano e dicono di noi in quanto abbiamo introiettato nella nostra vita il meccanismo dei social, che funziona sul consenso immediato e quantificabile in like e follower. Questa “macchina” agisce come un pensiero magico che ci illude, attraverso la reputazione di cui godiamo virtualmente di essere accettati e amati. A vantaggio della formazione di nuovi conformismi».
In sintesi, facciamo bene o no a coltivare la nostra reputazione?
«Prima va differenziata: c’è la reputazione che ha che fare con la postura etica e quella che, invece, è essenzialmente popolarità. Scegliere l’una o l’altra, spinge verso scelte di campo ben diverse».
La declinazione illuminante qual è?
«Dovremmo concentrarci più sulla parte etica della reputazione. Coltivarla ci porta a impegnarci sulla responsabilità delle nostre azioni: corrisponde a qualcosa che riteniamo corretto, giusto e non viene assecondata per rincorrere il plauso degli altri rispetto a un nostro comportamento, magari pagando il prezzo di tradire la nostra essenza. È una distinzione molto importante. Peccato che in questo momento il concetto di reputazione etica e quello di reputazione moralistica sembrino molto appiattiti l’uno sull’altro».
Avere una buona (o una cattiva) reputazione quanto incide sul nostro quotidiano?
«Dipende dallo spazio che diamo alla reputazione. Penso che una persona debba prendersi anche la libertà di fare qualcosa che possa non piacere. Di questi tempi, in cui la reputazione è essenzialmente “celebrità” sui social e in cui siamo bravi a capire cosa vuole il nostro pubblico, bisognerebbe essere almeno disposti – non è essenziale farlo – a perdere qualche pezzetto di “fama”. Altrimenti, si corre il rischio di non essere mai consapevoli delle nostre azioni».
Però, la reputazione è fragile, come un vaso di cristallo. Basta niente per incrinare la nostra e quella degli altri…
«Certo, come succede alla protagonista del mio romanzo dove, anche in assenza di indizi, viene additata come sospetta numero uno della sparizione di una ragazzina! Nella creazione di una certa reputazione, la parola (sotto la voce maldicenza, diceria, pregiudizio, pettegolezzo, ecc) vince sul fatto sostanziale. Non c’è da stupirsi: in fondo, noi basiamo tutta la nostra struttura cognitiva sui dati che riceviamo dalle sensazioni, e se sono illusorie in un battibaleno le trasfiguriamo in realtà; siamo portati a giudicare una certa situazione, una determinata persona sulla spinta di un input emotivo.
Da qui può partire l’effetto boomerang: basta avere paura di qualcosa che non possiamo controllare, di un microcosmo diverso dal nostro, di qualcuno che si distingue in qualche modo o che non riusciamo a decifrare immediatamente per trasformarlo in un mostro, una creatura da allontanare. Questa cosa è successa più volte e continua a succedere. Per valutare il valore morale di qualcuno raramente ci prendiamo la briga di andare a scandagliare i fatti, lavoriamo di più sulla superficie. Anche perché la reputazione ha una forza conservatrice, reazionaria, molto forte. E tende a rigettare in malo modo tutto ciò che scombina lo status quo».
Però, ci si può rifare una reputazione?
«Non è facile, ma neppure impossibile. La vita continua e macina reputazione senza fermarsi. Uno show che ci passa ininterrottamente sotto gli occhi: lo stesso personaggio, un giorno è il simbolo della buona reputazione, l’altro cade in disgrazia e viceversa, secondo gli algoritmi delle nuove tecnologie. È come essere immersi in un vortice di giudizi morali che cambia continuamente direzione ma ha un punto fisso d’orientamento: nel nostro mondo, ormai, ogni cosa, grave o non grave, finisce sempre nel serbatoio dell’indifferenza sociale».
Fai la tua domanda ai nostri esperti
Leggi anche
Tag: paura del giudizio.